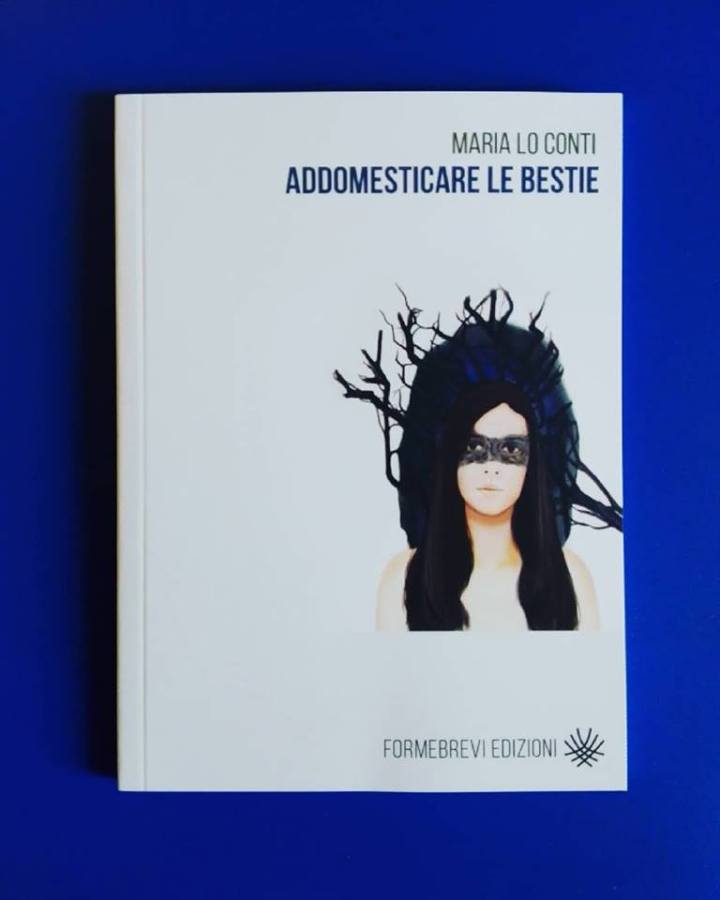Il tre luglio mi manchi, non so dove cercarti. Odio la mail di notifica del sito sull’albero genealogico che mi ricorda il tuo compleanno. Mi ero iscritta anni fa, ero lontana, avevo una vita ma me ne mancava un’altra, come sempre. Tre luglio ventisei, ho messo la tua data di nascita, la più cara. Quella di morte non l’ho messa mai. Sono passati due anni, la ferita non la guardo, se la guardo perde ancora sangue.
L’anno che sei morto mi sono sposata. Te l’avevo detto a dicembre, durante le vacanze di Natale. Nonno, io e Giovanni abbiamo deciso di sposarci. Tu hai annuito e hai detto Mi sembra una cosa buona. Mi tenevi la mano tra le tue mani, come facevi sempre, me l’hai stretta un poco. Io mi sono messa a ridere, ti ho accarezzato un sopracciglio, folto, grigio, disordinato. Le ragazze volevano organizzare l’addio al nubilato il tre di luglio, era domenica. Non posso, devo andare al cimitero. L’hanno spostato al giorno prima, siamo andate a Taormina, mi hanno messo una fascia con sopra scritto sposa, un cerchietto vagamente osceno, faceva caldo, ero felice.
L’anno scorso lavoravo. Un giorno inutile qualsiasi. Non sono potuta venire a trovarti. Quando vengo da te al cimitero mi riprometto sempre di raccogliere i soldi per farti una lapide come si deve, di cercare un’altra foto in cui non sembri arrabbiato; pulisco con cura il pavimento dalle erbacce, i fiori secchi e i vermi. Lo lavo e mi viene sempre in mente un verso di Brecht, anche la terra nuda tu rinfrescala, e le volte in cui la sera passavo la scopa e lo straccio attorno al tuo letto. Poi faccio un pensiero che vorrei evitare: penso al tuo corpo e mi chiedo a quale stadio di decomposizione sia giunto, cosa sia rimasto di te a questo punto, quante ossa, quanti denti, quanti capelli. È una visione orribile ma mi conforta, mi dice che di te esiste ancora qualcosa.
Quella foto l’abbiamo scattata un pomeriggio in terrazza. Ti serviva una fototessera nuova per la carta d’identità. Era estate, avevi una camicia chiara e i pantaloni corti. Per fare la foto hai indossato anche la giacca e la cravatta. Ancora camminavi, non tanto, non bene, appoggiato a qualcuno o a qualcosa, ma camminavi. Ti sei messo uno sguardo grave, serio, da persona seria quale eri. Ma il risultato è che sembri troppo accigliato, forse era il sole, troppo arrabbiato, non sembri tu. Tu eri buono, avevi un cuore enorme che ha tenuto fino all’ultimo mentre gli altri organi cedevano, collassavano. Non eri severo, non era necessario, ti bastavano gli occhi, la fermezza della voce. Con me non hai mai gridato, non ti sei mai arrabbiato. L’unica persona al mondo. Anche per questo ti sono grata.
Nemmeno quest’anno sono venuta a trovarti. Sono a Catania, Giovanni lavora. Ho una bambina, si chiama Giuditta. Quando sono da mia madre – tua figlia – passo nella sua camera da letto e mi metto davanti allo specchio della cassettiera, faccio le smorfie, faccio ridere Giuditta, ma in realtà guardo la foto che c’è sulla cassettiera, una foto in cui sorridi debolmente e hai gli occhi buoni, la pelle del volto più lenta, più sottile. Ti guardo e penso che Giuditta ti piacerebbe, impazziresti per lei. Penso che in lei rivedresti me – non so perché, ma mentre tutti vedono Giovanni io so che tu vedresti me.